Benvenute e benvenuti a un nuovo numero di Capibara, una newsletter umanista che fa ridere ma anche pensare. Anche questa settimana, il numero di volte in cui ho pensato di mollare tutto per andare a raccogliere funghi sul Gran Sasso è stato di gran lunga superiore alle volte in cui ho pensato “va bene così dai”.
È molto difficile trovare qualcosa da dire sul lavoro che non sia già stato detto. Ho fissato lo schermo bianco del PC senza grandi risultati; dopo un po’ ho alzato lo sguardo su un’altra cosa bianca, il muro, dove due pezzi di scotch tengono fermo il manifesto del Festival della letteratura Working Class 2025, organizzato da Edizioni Alegre insieme agli operai ex Gkn di Campi Bisenzio.
Come faccio a parlare di lavoro se la mia esperienza è legata solo al terziario avanzato, che di avanzato ha solo la capacità di essere sostituito più facilmente dall’IA?
Poi ha pensato a Cesare Pavese. Lavorare stanca, non solo nel senso ovvio. Stanca anche come idea. Come peso che portiamo addosso, a volte senza nemmeno sapere perché. Poi ho pensato che il mio dubbio ha senso, ma fino a un certo punto, perché ragionando così verrebbe meno il senso di ciò che provo a fare, da qualche anno a questa parte, mandando queste email, fatte di parole e di voci collettive, di ascolto e di esperienze condivise; e perché, al contrario, darei potere al lavoro inteso come esperienza solo individuale e caratterizzante.
I lavori cominciano all'alba. Ma noi cominciamo un po' prima dell'alba a incontrare noi stessi nella gente che va per la strada. Ciascuno ricorda di esser solo e aver sonno, scoprendo i passanti radi - ognuno trasogna fra sé, tanto sa che nell'alba spalancherà gli occhi.
Lavorare stanca, Cesare Pavese
Ecco allora che ho scelto di parlarvi non tanto del lavoro in sé, quanto di come ci plasma, ci definisce, ci logora. E di come, forse, potremmo iniziare a ripensarlo.
Per questo ho registrato anche un episodio del podcast, uscito il Primo Maggio, che si concentra, invece, sulla dimensione collettiva e politica e vede anche il contributo di Michele Di Paola, operaio del Collettivo di fabbrica Gkn.
"Che lavoro fai?" è spesso la prima domanda che ci rivolgiamo quando conosciamo qualcuno. Non "Cosa ti piace?", non “Qual è il tuo dinosauro preferito?”, ma "Che lavoro fai?".
Una domanda che sembra innocente, ma che nasconde una convinzione culturale profonda: siamo quello che produciamo.
Secondo l’ISTAT, la centralità del lavoro nell’identità individuale rimane forte soprattutto nelle generazioni adulte, mentre inizia a ridursi tra i più giovani.
Tuttavia, a livello collettivo, il lavoro continua a rappresentare uno degli elementi principali attraverso cui ci sentiamo riconosciuti, utili, “in società”.
Il sociologo Richard Sennett, in La corrosione del carattere, ha descritto un mondo in cui il lavoro non è più una costruzione lenta di senso, ma un accumulo di incarichi frammentati, di competenze usa e getta. Costruire un’identità stabile diventa così un’impresa disperata, destinata a fallire.
Anche perché l’alienazione si insinua ovunque. Dai lavori più tradizionali e d’ufficio ai nuovi impieghi. Da una parte trionfa l’estetica impersonale dei cubicles, il lavoro standardizzato e la frammentazione delle relazioni professionali, dall’altra si alimenta un senso crescente di estraneità. Persino nei nuovi mestieri apparentemente liberi e creativi.
Si è parlato di quiet quitting, che nasconde la volontà di mollare il lavoro e di non impegnarsi nel farlo. Si è parlato del rifiuto della Hustle culture, in altre parole tutto ciò che mira a dare priorità ad ambizione, produttività e successo, a spese di benessere mentale, vita equilibrata e cura di se stessi. In effetti, il mito del successo e della realizzazione personale nel lavoro è crollato, e sembra essere passato attraverso ciò che ha sperimentato Kafka quando lavorava all’Istituto di Assicurazione contro gli infortuni.
Pur non costituendo la realizzazione delle sue ambizioni, ha bisogno di quel lavoro e si impegna a portarlo avanti con serietà. Certo, le condizioni non sono ottimali: 80 corone mensili per ritrovarsi immerso in universo fatto di capi pretenziosi e dipendenti semi-sfruttati. Franz va avanti, sognando missioni all'estero che però tardano ad arrivare.
Nonostante tutto, il ragazzo avanza nella carriera: da assistente a segretario superiore in meno di un anno. Grande prova di resistenza se si considera che in una missiva confidava:
Sono alle Assicurazioni Generali, nutro però la speranza di sedermi un giorno sulle sedie di paesi molto lontani, di guardare dalle finestre dell'ufficio su campi di canna da zucchero o cimiteri musulmani, e il ramo assicurazioni mi interessa molto, anche se per il momento il mio lavoro è triste.
L'impiegato Kafka si licenzia dalle Assicurazioni Generali per motivi di salute il 15 luglio 1908. Comincia a lavorare per lo Stato nel luglio 1908: se ne sta in ufficio fino alle 14:00, dorme durante il pomeriggio, scrive di notte.
Il tempo sembra non bastargli mai. L'impiego è gravoso, inconciliabile con la scrittura. Nella pagina di diario datata 28 marzo 1911, si sfoga:
Queste due professioni non si possono mai conciliare né ammettono una felicità comune. La più piccola felicità nell'una diventa una grande infelicità nell'altra. Se una sera scrivo qualcosa di buono, il giorno dopo in ufficio sto sulle spine e non riesco a combinare niente.
Insomma, un malessere che tormenterà Kafka per tutta la vita, al punto da diventare fulcro del racconto più noto: Le Metamorfosi. Nell'esistenza di Gregor Samsa, impiegato protagonista dell'opera la cui vita viene sconvolta dalla trasformazione in insetto, si riflette l'ossessione verso la routine e l'ordinario.
[In questo vecchio numero di Capibara ho parlato dell’importanza della noia, lusso dimenticato, e ancora di lavoro, in relazione a tempo libero e salute mentale.]
Eppure, anche in un sistema che cambia a una velocità spaventosa, continuiamo ad aggrapparci all’idea che il nostro valore passi da lì. Come se smettere di lavorare significasse smettere di esistere.
Ma cosa succede quando il lavoro è precario, intermittente, sottopagato o addirittura assente? Succede che chi non lavora tende a sparire, non solo dal mercato, ma anche dalla narrazione sociale. Secondo i dati ISTAT, l’Italia resta il paese europeo con il più alto tasso di inattività (oltre il 33% tra i 15 e i 64 anni), con picchi che colpiscono donne, giovani e persone del Mezzogiorno.
Non è solo una questione economica: è una questione di riconoscimento, di dignità, di visibilità.
"Chi si impegna, ce la fa." Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere?
Peccato che i dati raccontino tutta un’altra storia.
Secondo l’OCSE, in Italia servono cinque generazioni per salire dalla fascia di reddito più bassa a quella media. Significa che chi nasce povero oggi, vedrà i risultati del proprio impegno – forse – tra i bisnipoti (che non avremo). Nel frattempo, chi parte avvantaggiato accumula privilegi, titoli, contatti, stabilità.
Il filosofo Michael Sandel, in La tirannia del merito, lo dice chiaramente:
La meritocrazia non ha creato una società più giusta, ha solo costruito un’aristocrazia della bravura.
E in Italia, questa aristocrazia ha numeri ben chiari:
Il 30% dei dipendenti privati si trova in fasce di bassa retribuzione annuale.
Il potere d’acquisto delle retribuzioni è calato del 4,5% nell’ultimo decennio.
Il 10% più ricco guadagna 4,5 volte più del 10% più povero.
Il CEO medio porta a casa 5,7 milioni l’anno, mentre lo stipendio medio annuo dei dipendenti non supera i 30.000 euro.
E poi c'è il lavoro che non si vede: quello domestico e di cura. Secondo l’Osservatorio Nazionale sul Lavoro Domestico, le donne italiane svolgono 5 ore al giorno di lavoro non retribuito, contro 1,5 ore degli uomini. Un’attività che, se contabilizzata nel PIL, lo farebbe crescere di circa il 30%.
Quindi sì, lavorare sodo può pagare. Ma spesso ripaga qualcun altro.
La meritocrazia è una fiaba raccontata ai bambini per farli addormentare. Ma gli adulti dovrebbero aver capito che non basta il merito, quando mancano le condizioni.
E poi c’è la Gen Z: una generazione che sta rivoluzionando il modo in cui si rapporta al lavoro. Non perché sia pigra – ma perché ha capito quanto possa essere fragile, e a volte tossico, il patto implicito tra lavoro e riconoscimento.
Si dice che le manchi un’etica del lavoro, ma è davvero la Gen Z ad esserne priva o sono tutti gli altri a non averne?
Nell’agosto 2024, il sito Intelligent.com ha intervistato 966 manager coinvolti nei processi decisionali riguardanti l’assunzione di nuovi dipendenti. L’obiettivo era capire l’attitudine con cui si assume un neolaureato Gen Z e l’opinione che i recruiter hanno di questa generazione. Nel corso dell’anno, il 94% delle compagnie aveva assunto persone nate tra il 1997 e il 2012 recentemente laureate, ma solo in una su quattro queste assunzioni si erano rivelate “di successo”.
Tuttavia appare improbabile che la Gen Z possa rinunciare a un modo di interpretare la realtà maturato negli anni della formazione: la necessità di raggiungere un equilibrio sano tra impegno professionale e vita privata, la possibilità di crescita e di riconoscimento, la cura della propria salute mentale e fisica costituiscono dei punti cardine, insindacabili e non negoziabili. Tra le ragioni indicate per cui l’assunzione di un laureato Gen Z è stata ritenuta insoddisfacente c’è infatti anche un “bad culture fit” — un cattivo adattamento alla cultura dominante nell’ambiente aziendale di appartenenza. Questa generazione sceglie di selezionare i progetti a cui dedicarsi e i manager con cui lavorare.
Una buona paga non è tutto e soprattutto si rivela insufficiente a garantire un rapporto virtuoso e duraturo fra dipendente e azienda. Infatti, entrano in gioco altri parametri, come la flessibilità, l’attenzione alla distribuzione equa dei meriti, la trasparenza e l’empatia. Anche in mancanza di nuove opportunità, i neo-dipendenti non temono di cambiare strada e di abbandonare il proprio lavoro.
[Ho in ballo un numero tutto sulla Gen Z, forse il prossimo, non so. Se sei un lettore o una lettrice nato/a tra il 1997 e il 2012 e ti va di contribuire a questo numero, rispondi pure a questa mail.]
Secondo l’indagine Flair 2025, il 65,5% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vorrebbe lavorare meno per vivere meglio. E il 34,7% ammette di “fare il minimo indispensabile”, una forma di resistenza tranquilla: niente straordinari, niente mail serali, niente ansia performativa. Una generazione che non vuole essere “ambiziosa a ogni costo”, ma semplicemente vivere senza bruciarsi.
Con stipendi stagnanti, contratti a termine, affitti alle stelle, la promessa di "lavorare duro e costruirsi un futuro" è percepita come una truffa.
Un esempio è il boom di dimissioni volontarie tra i 25-34enni che si è registrato, negli ultimi due anni, in Italia come in gran parte dell’Occidente. Non è solo fuga dal precariato: è rifiuto di modelli insostenibili.
Come dice la sociologa Francesca Coin:
I giovani non stanno abbandonando il lavoro: stanno abbandonando il mito del lavoro come sacrificio cieco.
Il lavoro non è più il centro. È un pezzo della vita. E se quel pezzo diventa ingombrante, si taglia, si cambia, si lascia.
Adesso, quindi, siamo in una situazione di forte instabilità: da un lato abbiamo una generazione che si affaccia al mondo del lavoro con un rinnovato sistema di valori, formato nel corso di anni significativi dal punto di vista sociale; dall’altro, le aziende che agiscono in un mercato che tende a chiudersi e contrarsi, e in un contesto geopolitico conservativo.
Con crescente difficoltà, quindi, le organizzazioni attraggono i cosiddetti giovani talenti, risultando meno attraenti ai loro occhi, dal momento che per la Gen Z la responsabilità sociale e l’essere sostenibili nel modo di trattare le persone e l’ambiente circostante costituiscono dei punti non oggetto di trattative.
Qui ci viene in aiuto Matteo Roversi, co-founder di Cosmico e autore della newsletter Work After che, dopo il contributo audio per il podcast, ha accettato di farne anche uno scritto.
Ci ripetiamo che il lavoro deve cambiare per andare incontro ai giovani, ma è un’illusione.
Le aziende si fondano ancora su logiche industriali: mansioni ripetitive, gerarchie rigide, titoli come garanzia di competenza.
Oggi quei pilastri non tengono più: i compiti standard passano alle macchine, la permanenza media in azienda è scesa sotto i tre anni e una laurea, da sola, non basta più a convincere chi deve assumerci.
Così molti giovani preferiscono inventarsi un lavoro, piuttosto che stare alle regole di un sistema che non li rappresenta.
Oppure mettono in atto strategie difensive come il job hopping, saltando da un posto all'altro: prendono ciò che un'azienda può offrire e la abbandonano appena sentono che non è più il posto per loro.
E cosa fanno le aziende in risposta?
Tentano di rendere più "piacevole" questo sistema con lo smart-working, i venerdì liberi o altri benefit creativi.
Cercano disperatamente di curare i sintomi, ma ignorano le vere cause della crisi: non percepiamo più valore umano in quello che facciamo perché dedichiamo tempo a problemi che non scegliamo e di cui non vediamo l’utilità.
L’intelligenza artificiale ci mette oggi di fronte all’urgenza di ripensare tutto il sistema.
Molti compiti che oggi svolgiamo saranno presto eseguiti direttamente dalle macchine.
La vera domanda diventa allora: quali problemi meritano davvero lo sforzo umano?
Quali sfide non potranno essere delegate a un algoritmo perché richiedono immaginazione, giudizio, responsabilità?
È questo il lavoro che dobbiamo fare, l’unica forma di lavoro autenticamente umana: perché l’essere umano è per natura problem solver e creatore, e il lavoro che ci appartiene è quello che ci trasforma, ci fa crescere e ci rende utili agli altri.
La creator economy, spesso liquidata come passatempo da influencer, è in realtà l’esperimento su larga scala di questo modello: il creator intercetta un problema, inventa una soluzione estetica o tecnica, mette in mostra il suo lavoro e si fa pagare per l’effetto che produce. È lavoro allo stato primario, prima che la catena di montaggio lo spezzettasse in micro-gesti. È forse la forma di lavoro più umana che possa esistere.
Portare questa logica al cuore delle aziende significa riscrivere le regole: il tempo non è più sinonimo di valore, la carriera lineare non misura più la competenza, e il manager-controllore diventa inutile se le informazioni sono accessibili e i risultati visibili a tutti. Le imprese che capiranno questa evoluzione diventeranno piattaforme aperte, dove i problemi emergono, vengono risolti da chi ne è capace, remunerati per il risultato e documentati apertamente per alimentare nuove soluzioni.
Non esiste decreto o ufficio HR che possa imporre questa transizione.
Accadrà perché una generazione libera da vecchie gerarchie e ruoli si metterà a produrre valore altrove.
E a quel punto le aziende avranno solo due scelte: adattarsi a questo nuovo modello, oppure cercare di difendere le loro gerarchie e ruoli nell'attesa che sia un algoritmo a smantellarle.
Il lavoro non cambierà per accontentare i giovani.
Cambierà perché i giovani lo stanno già cambiando altrove, e chi vuole restare in partita dovrà giocare secondo le loro regole, non viceversa.
Il Primo Maggio nasce nel 1886, a Chicago, tra scioperi, cariche di polizia, morti.
Nasce per reclamare qualcosa che oggi tendiamo a dare per scontato: 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore per sé.
Oggi quelle 8 ore sembrano spesso un compromesso lontano. Si dilatano, si spezzano, si frammentano. Il diritto alla disconnessione resta ancora sulla carta. Il salario minimo è in discussione da anni, senza grandi risultati.
Come ricorda Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione ADAPT:
Il problema non è solo quanti lavorano, ma come si lavora.
Ed è proprio su questo “come” che si gioca la differenza tra avere un lavoro e costruire una vita.
Forse la questione non è avere un'occupazione, ma capire se il lavoro che abbiamo lascia spazio a tutto il resto: il tempo per noi, per gli altri, per quello che non è produttività.
David Graeber, in Bullshit Jobs, lo riassume così:
Abbiamo costruito un sistema in cui si lavora senza scopo. Solo per lavorare.
Nel suo libro, Graeber definisce bullshit job un lavoro talmente privo di utilità – o addirittura dannoso – che persino chi lo svolge è convinto che il mondo starebbe meglio senza. Ma il sistema ti obbliga a far finta che serva a qualcosa.
Un receptionist in un ufficio dove non squilla mai il telefono? Bullshit. Un manager messo lì solo per supervisionare persone che non hanno bisogno di essere supervisionate? Bullshit. E ce ne sono molti di più.
C’è un equivoco da chiarire: un lavoro di merda non è necessariamente un bullshit job. Anzi, più un lavoro è duro, sottopagato e invisibile, più è probabile che sia davvero utile. Prendiamo chi pulisce i bagni o assiste gli anziani: spesso ha condizioni lavorative pessime, ma il suo contributo è reale, concreto. È quello che Graeber definisce un "lavoro di cura". Insomma, fa schifo ma serve. I bullshit jobs, invece, sono ben pagati, rispettati, ma non servono a nulla.
Secondo Graeber, la soluzione non è creare altri lavori inutili con politiche “garantiste”, ma dare alle persone la libertà di scegliere. Il reddito di base universale è un’idea sensata: garantire a tutti la possibilità di vivere, senza dover giustificare ogni centesimo con un mestiere insensato. Perché, come ha scoperto parlando con decine di lavoratori depressi e demoralizzati, nessuno vuole davvero essere pagato per far nulla. La maggior parte di noi ha bisogno di sentirsi utile.
Anche solo per non impazzire in un open space mentre si finge di compilare fogli Excel che non interessano a nessuno, sennò tanto vale andare a raccogliere funghi sul Gran Sasso!
In fondo, il messaggio è semplice: il lavoro dovrebbe servire a migliorare la vita delle persone, non a riempire le giornate per far contenti i capi. E, forse, potremmo cominciare a cambiare le cose smettendo di far finta che tutto questo abbia un senso.
Se volete approfondire, oltre a leggere il libro, vi rimando a questo articolo de Il Tascabile.
Il Primo Maggio non dev’essere solo una ricorrenza rituale o luttuosa, ma un’occasione concreta di lotta. Quest’anno ci sono cinque buoni motivi in più per mobilitarsi: i referendum dell’8 e 9 giugno. I temi sono caldi: abolire i licenziamenti senza giusta causa del Jobs Act, risarcire meglio chi perde il lavoro ingiustamente nelle piccole aziende, ristabilire vincoli più rigidi per l’utilizzo del lavoro a tempo determinato, rendere responsabili gli appaltatori per infortuni sul lavoro, e riconoscere la cittadinanza dopo 5 anni a chi lavora o studia in Italia.
La precarietà, i salari bassi, i contratti fragili non sono sfortuna, ma il frutto di precise scelte politiche. Il governo parla di boom occupazionale, ma i numeri reali raccontano un’altra storia: non posti veri, ma contratti precari trasformati.
Insomma, dietro le fanfare del “lavoro che cresce” c’è un sistema che sfrutta e svaluta il lavoro. Il referendum diventa l’occasione per dire basta a questo modello economico, e per riprendersi voce e dignità.
Perché se in un giorno all’anno si celebrano i lavoratori, in tutti gli altri la festa è solo dei padroni. Allo scoccare del primo quarto di secolo, la forma dell’attuale modo di produzione risulta più che mai chiara: un restaurato capitalismo di puro comando. Dove la proprietà ordina e lavoratrici e lavoratori eseguono.
Il Primo Maggio dovrebbe essere anche questo: non solo un'occasione per ricordare cosa si è conquistato, ma per interrogarsi su cosa stiamo perdendo.
Per questo quarantaquattresimo numero di Capibara è tutto. Voi come vi sentite rispetto al vostro lavoro? Vi rappresenta? O è solo un peso? Raccontate.









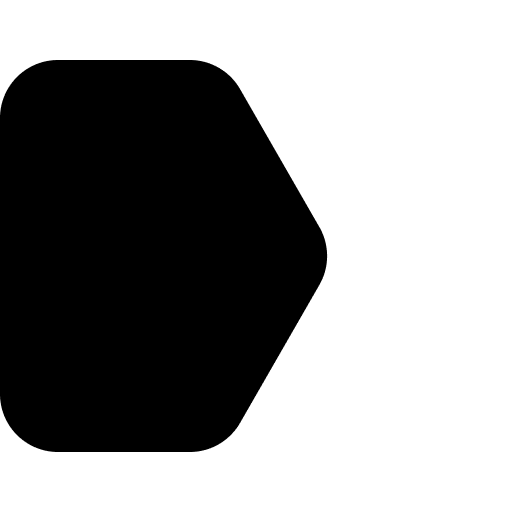


Per lavoro da ventitré anni produco bottoni, il che idealmente è qualcosa di utile. Ma lo faccio anche per forze dell'ordine di cui non sempre approvo l'operato, per aziende di moda che fanno pagare i loro capi molto più di quanto sarebbe lecito farli pagare (il mio è tutto tranne che un mestiere pulito, ma immagino di essere una delle rotelle con condizioni migliori all'interno della filiera), per istituzioni che cambiano divise con una cadenza che mi fa chiedere "era davvero necessario?" Interrogarsi sulla necessità e sostenibilità del proprio lavoro è uno dei migliori modi per complicarsi la vita, ma è necessario per farsi una coscienza critica.
Io insegno. Ho scelto questo lavoro proprio perché ha significato, e perché vedo i risultati quasi quotidianamente - a volte i risultati di cinque anni prima, a volte quelli del lavoro del giorno precedente, ma in continuazione mi ricordo del perché faccio questo lavoro.
Non potrei mai fare qualcosa di insensato, col mio carattere o mi licenzio subito o cado in una depressione tale da puntare all'estremo gesto, e dico sul serio.