Benvenute e benvenuti a un nuovo numero di Capibara, una newsletter umanista che fa ridere ma anche pensare. Che dire? “C’è la crisi c’è la crisi, da domani acquisto solo cacciabombardieri”. E a proposito di crisi e di cacciabombardieri, oggi parliamo di passioni. Non quelle che infiammano, ma quelle che si, e ci, consumano piano.
Parliamo di passioni tristi, termine reso celebre da Miguel Benasayag e Gérard Schmit (Feltrinelli, 2013), due psichiatri che hanno osservato un aumento del disagio psicologico nelle nuove generazioni. Il concetto nasce da una riflessione di Spinoza, che definiva "passioni tristi" quelle emozioni che ci rendono più deboli e vulnerabili, più inclini a subire che ad agire. Oggi viviamo in un mondo in cui queste passioni sembrano aver preso il sopravvento: ansia, frustrazione, impotenza, incertezza.
Fino a qualche decennio fa, il futuro era qualcosa di promettente. Si cresceva con l’idea che ogni generazione avrebbe avuto più opportunità della precedente. Ora invece ci dicono che sarà peggio, o magari “non cielo dicono” ma possiamo notarlo anche da soli. L’ideologia della crescita è stata sostituita dall’ossessione della crisi. Il futuro non è più un orizzonte di possibilità, ma un luogo oscuro e minaccioso. Forse comunque un orizzonte, ma più simile all’orizzonte degli eventi.
Quando ancora esisteva la storia, il futuro era una terra promessa da raggiungere spezzando le catene politiche, economiche e ideologiche cui eravamo avvinti. La parola chiave era speranza, declinata nella prassi del progresso: la modernità si incarnava nella psicoanalisi di Freud che vedeva il negativo come parte del processo positivo di liberazione tramite la terapia, o nella filosofia di Marx che lo individuava nello sfruttamento capitalista, superabile attraverso la coscienza e la lotta di classe.
Eppure, con “la fine della storia”, si è proclamata l’era dell’individualismo. Ricordiamo la celebre frase di Margaret Thatcher: «non esiste la società, solo gli individui», che ha portato il filosofo dei non-luoghi, Augé, a chiedersi: «che fine ha fatto il futuro?»
E così ci difendiamo, ma lo facciamo male.
Secondo il rapporto dell’OMS del 2023, i disturbi d’ansia e depressione sono aumentati del 25% rispetto al decennio precedente. In Italia, secondo l’ISTAT, quasi il 20% dei giovani tra i 18 e i 24 anni manifesta sintomi depressivi o ansiosi. Lo conferma anche un’indagine condotta dall’Università di Bologna: mai come oggi i giovani si sentono insicuri e disorientati.
Non si tratta solo di una maggiore consapevolezza diagnostica, ma di un malessere reale che attraversa tutte le classi sociali. Non è un caso che il tasso di burnout sia in crescita non solo tra i lavoratori, ma anche tra gli studenti delle superiori e dell’università. L’esaurimento non è più il risultato di una carriera ultracompetitiva, è la condizione di partenza.
I social network, anziché creare connessioni reali, amplificano la sensazione di inadeguatezza. Uno studio pubblicato su Nature Human Behaviour dimostra che l’uso eccessivo dei social è correlato a un aumento dell’ansia e della depressione. Ci confrontiamo costantemente con vite perfette e successi altrui, sentendoci sempre un passo indietro.
Ma non sono solo i social. C’è qualcosa di più profondo che ci sta trasformando in una generazione perennemente insoddisfatta e inquieta.
Viviamo in una società che ci dice che possiamo (anzi, dobbiamo) essere unici, ma che poi ci lascia soli nel farlo. L’individualismo sfrenato ci ha convinti che il successo sia un percorso esclusivamente personale, che la felicità dipenda solo da noi. "Se non ce la fai, è colpa tua."
Secondo il filosofo Miguel Benasayag, questa narrazione è una delle principali cause delle passioni tristi. Nel suo saggio, scrive che il problema non è solo psicologico, ma politico e sociale:
“Le persone oggi non si sentono infelici solo perché hanno problemi personali, ma perché la società le ha private degli strumenti per costruire collettivamente un senso.”
Siamo iperconnessi, ma isolati. Abbiamo più possibilità, ma meno senso di appartenenza. Tutto è misurato in termini di performance, produttività, risultati.
Tutto deve servire a qualcosa. Questo è il mantra della nostra epoca. Studiare? Deve portarti a un lavoro redditizio. Fare sport? Devi avere addominali scolpiti. Leggere? Solo se è un manuale di self-help che ti spiega che per fare tanti soldi devi svegliarti presto e avere già tanti soldi.
Anche il tempo libero è diventato un lavoro. L’ossessione per l’ottimizzazione ha invaso ogni angolo della nostra vita. Guy Debord parla di "società dello spettacolo" (Baldini Castoldi, 2017), Byung-Chul Han di "società della stanchezza” (Nottetempo, 2020), io di società della performance: non ci sentiamo sfruttati da un padrone esterno (anche), ma da noi stessi. Ci auto-sfruttiamo, credendo che sia libertà.
Il risultato? Stress. Ansia. La sensazione di non essere mai abbastanza. Il Financial Times ha definito questa condizione "productivity shame": la vergogna di non essere sempre al massimo. Ma al massimo di cosa?
I giovani di oggi vengono educati a un futuro che non esiste più. La scuola continua a ripetere che il merito verrà premiato, ma poi il mondo del lavoro dimostra l’esatto contrario: precarietà, stipendi bassi, un sistema che non garantisce nulla. Il sociologo Maurizio Ambrosini ha parlato di una "generazione sospesa", intrappolata tra aspettative irrealistiche e una realtà che non offre stabilità.
Non è un caso che il disagio mentale colpisca soprattutto chi è più precario. I dati dell’ISTAT confermano che i lavoratori con contratti instabili hanno una probabilità tre volte superiore di soffrire di ansia e depressione rispetto a chi ha un impiego sicuro. Eppure continuiamo a educare i ragazzi come se la stabilità fosse ancora un’opzione per tutti.
Un’altra parola magica del nostro tempo è resilienza. Ti dicono che devi imparare a resistere, a rimanere flessibile, a rimbalzare dopo ogni caduta. Ma la resilienza, senza un contesto che ti supporti, diventa solo un modo per dire: "arrangiati".
Il filosofo Alain Ehrenberg, nel libro La fatica di essere se stessi (Einaudi, 2010), ha analizzato come la società moderna abbia trasformato la depressione da malattia clinica a responsabilità individuale. Se sei depresso, è perché non sei abbastanza forte. Se sei stressato, devi solo lavorare su te stesso.
Ecco perché, invece di una vera ribellione, assistiamo alla versione di Inside Out scritta da Bong Joon-ho e diretta da Yorgos Lanthimos, dove le emozioni sono rancore, odio online, polarizzazione estrema, nichilismo, Elon Musk. L’individualismo ci ha convinti che dobbiamo salvarci da soli, che il problema è sempre l’altro. Nel frattempo, il potere economico e politico continua a operare indisturbato, alimentando il nostro risentimento per tenerci fermi, bloccati.
Non siamo, però, progettati per farcela da soli. La nostra forza è nella comunità, nella condivisione, nella costruzione collettiva del senso.
La buona notizia è che esiste una via d’uscita. Invece di vedere gli altri come concorrenti, possiamo iniziare a considerarli alleati. Invece di inseguire il successo individuale, possiamo riscoprire il valore del fare insieme. Creare reti di supporto, coltivare passioni senza scopo immediato, ridare valore a ciò che non serve a nulla, ma che ci fa sentire vivi.
La soluzione potrebbe sembrare banale, ma è riscoprire il piacere delle cose inutili. Benasayag e Schmit insistono su questo punto: per spezzare il ciclo delle passioni tristi, dobbiamo recuperare la gioia del fare disinteressato. In un mondo che ci dice che ogni passione deve diventare un lavoro e ogni hobby una monetizzazione, dobbiamo imparare di nuovo a fare le cose senza aspettarci un ritorno immediato. Suonare uno strumento senza pensare di uscire per Universal. Scrivere senza puntare al capolavoro (tanto fra il tuo libro e la biografia di Gerry Scotti sceglieranno il secondo). Fare sport senza l’ossessione della performance. Costruire legami senza paura di perdere tempo.
Non è una fuga dalla realtà, è un atto di resistenza.
Per questo quarantesimo numero di Capibara è tutto. Non era previsto dovessi trattare questo tema, ne avevo iniziato un altro e poi ho chiuso tutto, ho riaperto e iniziato di nuovo e, ora, arrivato alla fine son quasi commosso, sarà perché scrivo queste cose ma poi sono il primo che deve imparare a seguirle, saranno i Twenty One Pilots in sottofondo, sarà che, a volte, le cose sembrano accadere tutte nello stesso frangente e ci si sente un po’ come Boromir alla fine de La Compagnia dell’Anello.
Vabè, a proposito di passioni tristi, di società della performance e della sensazione di dover fare sempre qualcosa, per essere produttivi o per occupare il tempo, vi rimando all’ultimo episodio di Capibara il podcast, dove parlo di quel lusso proibito e temuto chiamato noia, con un gran contributo di Ilaria Gaspari.
Ora fatemi sapere: voi cosa fate che non serve a niente ma vi rende felici?





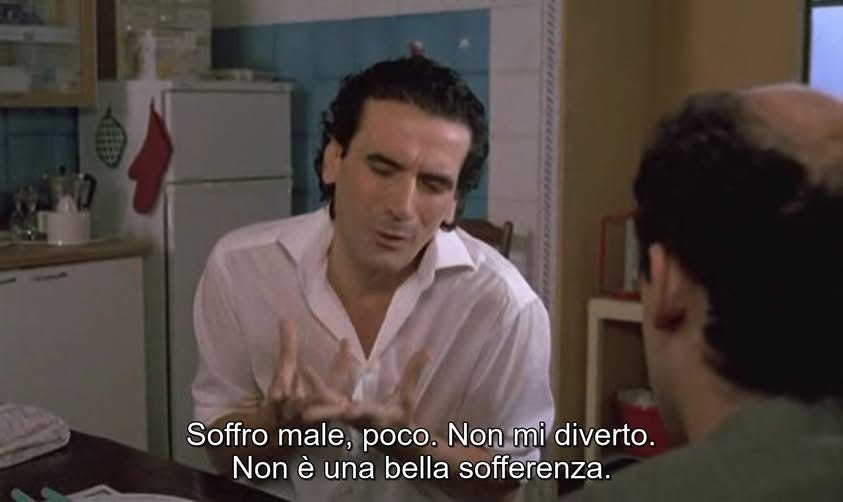
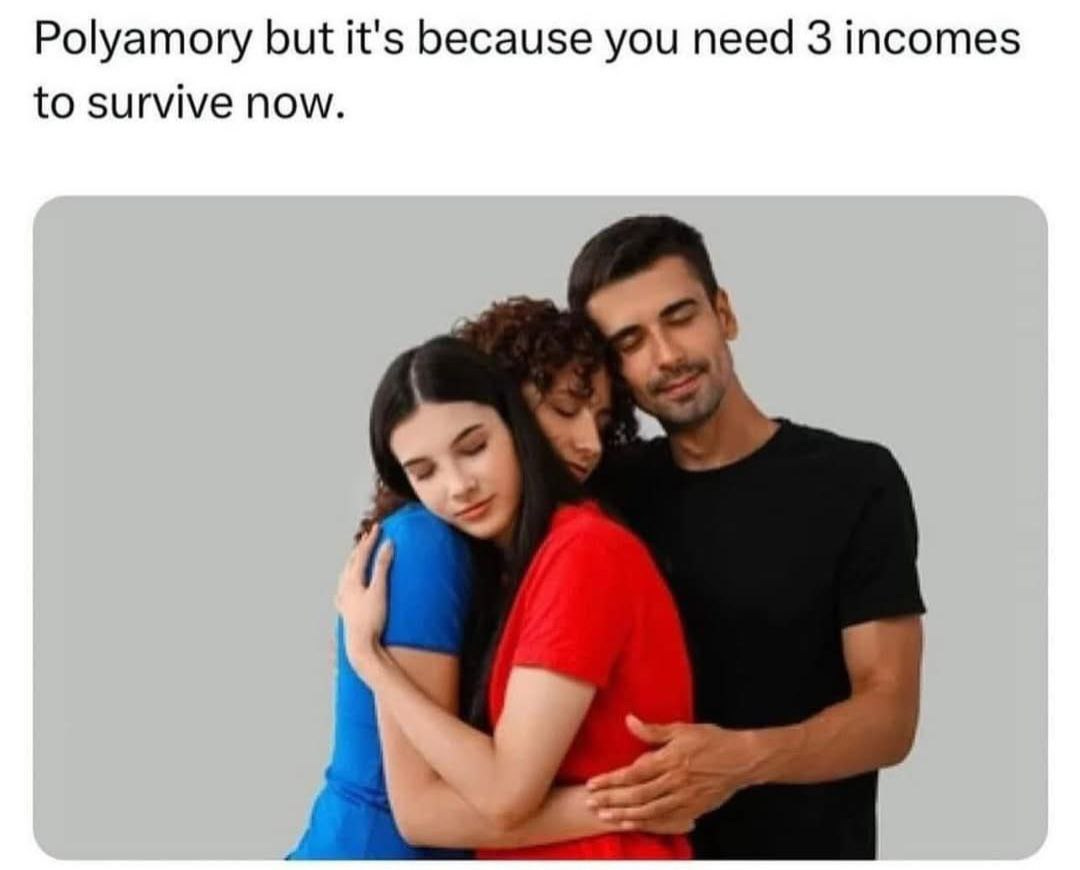
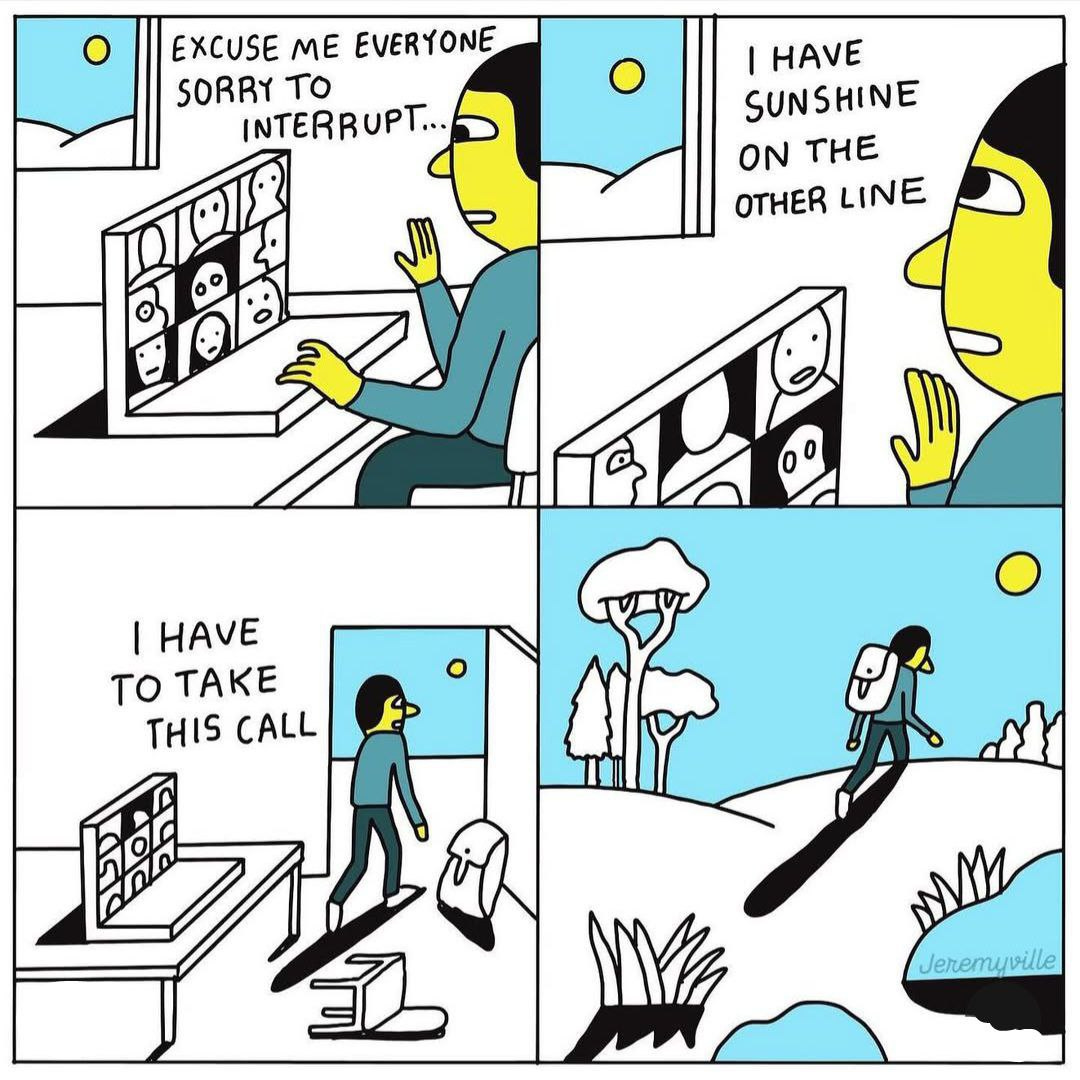



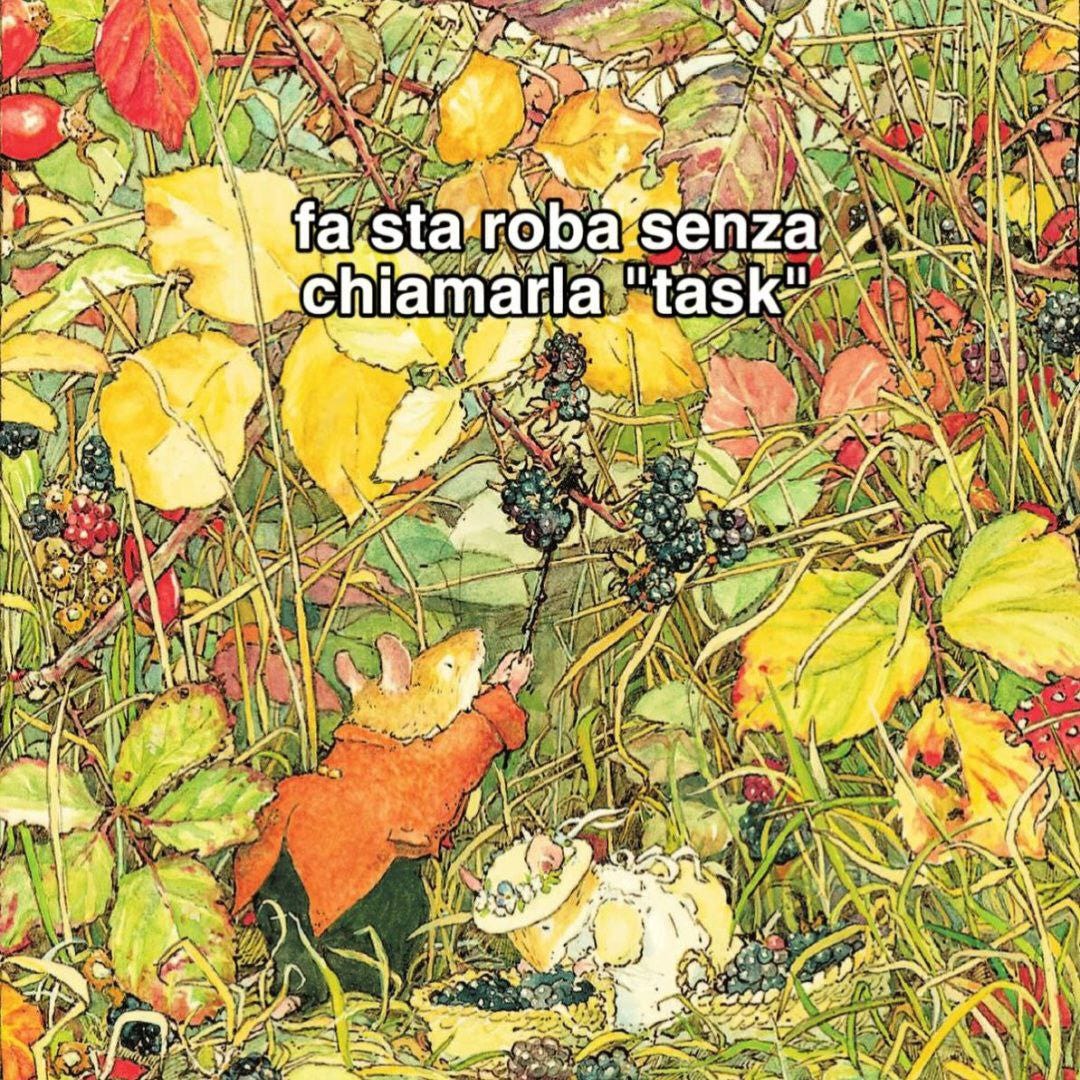
Io cucino dolci, cose un po' a caso, senza per forza seguire una ricetta. Ho anche un piccolo orto,vorrei occuparmene di più ma chissà perché finisce sempre in secondo piano rispetto agli "impegni veri"
È faticoso anche provare a fare le cose insieme in un sistema che funziona in tutt’altro modo. Da un lato per l’imposizione di una estrema competitività in ogni singolo passaggio, dall’altro perché quando si prova a fare diversamente chi ci è intorno ci guarda innanzitutto con sospetto, vista l’abitudine a tutt’altro modo di porsi reciprocamente. Io non mi arrendo, chiedo aiuto, tendo la mano, mi ostino a credere di non essere sola.